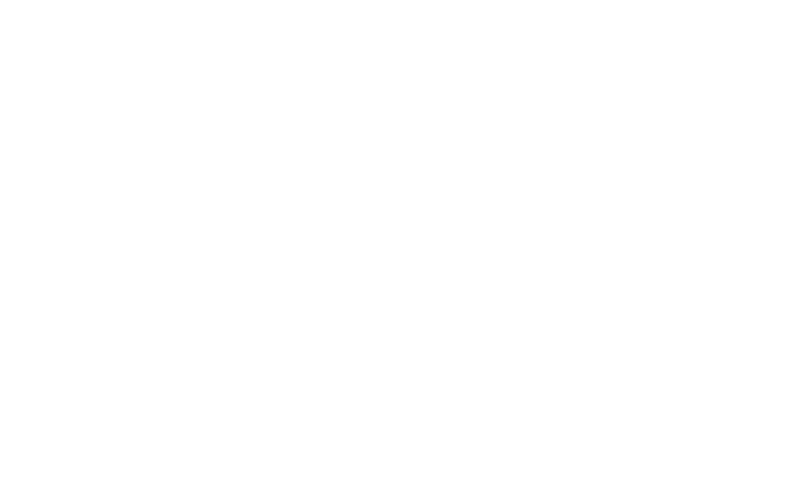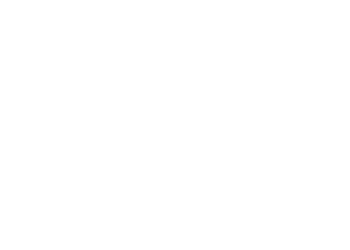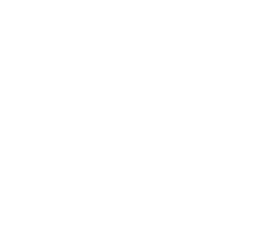Giuseppe Antonio Rocca, fece a Torino anno Domini 1839
Fuori dall’antica porta degli Archi, oltre il torrente Bisagno che separa la città storica di Genova dalle sue delegazioni orientali, alla metà dell’Ottocento stava la Pila: un borgo di poche case disteso sulla piana sotto la collina a vocazione residenziale di San Francesco d’Albaro, con terreni coltivati e una chiesa di origine duecentesca intitolata a Santa Zita, presso la quale si svolgeva il mercato delle vacche. Fu in uno di questi orti, di proprietà del Marchese De Ferrari, che in una mattina della fine di Gennaio del 1865 venne rinvenuto il corpo di un uomo, ormai senza vita, precipitato in un pozzo.
La magistratura chiuse presto l’inchiesta ritenendo l’accaduto un infortunio; il malcapitato venne identificato quale “Rocca Giuseppe da Alba fabbricante di strumenti a corda, qui dimorante”, di anni cinquantotto.
Si concludeva così l’esistenza sofferta di quest’uomo, insofferente ed inquieto come un più moderno personaggio di Cesare Pavese, segnato dal solco delle difficoltà economiche, dai lutti, dalle citazioni derivate dalle doti delle mogli scomparse e persino da una certa fatica nell’inserirsi nel mercato degli strumenti musicali. Eppure per quanto sappiamo, negli anni della sua giovinezza Rocca (nato a Barbaresco nel 1807) trascorse periodi felici con la sua prima moglie Anna Maria Calissano: la coppia, sposatasi nel Novembre del 1828, risiedeva ad Alba, non si occupava di violini bensì di pane, farina e pasta fresca, e fu presto rallegrata dalla nascita di una figlia, Teresa. Fu nel 1834 che Giuseppe Rocca, dopo avere precedentemente perso la madre e la sorella, vide morire la giovane moglie: decise quindi di lasciare Alba per raggiungere a Torino Giovanni Francesco Pressenda e tentare quella che secondo secondo quanto narrava Romano Marengo nel suo volume “Tre figli delle Langhe”, fu la sua prima passione: “essendogli venuto il capriccio di fare un contrabbasso, adoperò il legno della madia e poi con tutto il rimanente di quel legname costrusse viole e violini, apponendovi cartellini datati da Alba col nome di Giuseppe Antonio Rocca”. Sebbene non sia oggi verificabile l’attendibilità del racconto, possiamo credere che i due già si fossero conosciuti o fossero stati introdotti da qualcuno nell’ambiente: certo è che nella bottega di Pressenda il Rocca ebbe l’opportunità di apprendere la liuteria tanto da rendersi in poco tempo provetto nell’arte. Gli anni torinesi furono comunque travagliati, segnati da una serie di lutti e accidenti economici che qui si elencano brevemente: risposatosi con Caterina Barone, una giovane di buona famiglia torinese, e aperta nel 1838 bottega in proprio in via Po Rocca, a causa di una malattia che lo colpì assieme alla moglie, nell’impossibilità di lavorare e schiacciato da una pesante situazione debitoria, si dichiarò indigente onde poter riscuotere la dote della moglie; perso il padre nel 1839, ebbe ulteriori difficoltà a causa dell’eredità che favoriva la matrigna, e nel Gennaio del 1842 vide morire la seconda moglie. Risposatosi dopo pochi mesi con Giuseppina Quarelli, nipote della stessa Caterina Barone, ebbe da lei tre figli, Giovanni Battista, Francesco ed Enrico, il futuro liutaio.
Nonostante Giuseppe Rocca non avesse potuto mai contare per promuovere il proprio lavoro sull’appoggio di musicisti di fama, ebbe negli anni a seguire diverse ordinazioni, il suo laboratorio produceva un buon numero di strumenti ad arco e di chitarre, talvolta fornite di bassi aggiunti; nel Dicembre del 1850 tuttavia, a causa di una tisi polmonare, la moglie Giuseppina moriva lasciando Giuseppe vedovo per la terza volta.
La decisione di trasferirsi a Genova venne così a definirsi per varie cause: da un lato Giuseppe si trovava a Torino stretto dalla concorrenza non tanto dell’anziano maestro, quanto dell’agguerritissima bottega dei Guadagnini che poteva vantare salde alleanze con i liutai parigini; da un altro lato sentiva forte la necessità di lasciarsi alle spalle le tragiche vicende cambiando aria, bottega e città: di certo seppe sfruttare l’opportunità che la nuova strada ferrata, fortissimamente voluta dal conte di Cavour, offriva nel collegare la capitale sabauda a Genova, città che nelle intenzioni dell’amministrazione reale doveva rappresentare il futuro portuale e industriale del regno.
Rocca quindi non perse tempo: nel Luglio del 1851 si sposò con la genovese Emilia Dodero stabilendosi dopo qualche tempo nella centralissima via dei Sellai, a pochi passi dal teatro Carlo Felice; non rimase comunque stabilmente in città, anzi mantenne sempre un recapito a Torino, alternando la sua attività tra le due città.
Di come Rocca abbia perso la vita si è raccontato: va aggiunto che ad un certo punto si perdono a Genova le tracce di Emilia Dodero e che, al momento della morte, Giuseppe risultava sposato con Filomena de Franchi, una ragazza poco più che adolescente di professione “cucitrice”. Quando il figlio Enrico già anziano, con l’intento di difendere l’onorabilità del padre, ricordava che la sua fine fu dovuta non tanto all’abuso di alcol quanto ‘all’infame condotta della moglie Emilia Dodero’ che, a parer suo, lo condusse al suicidio, non sapeva, o forse taceva Enrico il fatto che Emilia non era la seconda moglie bensì la quarta, a cui ne seguì una quinta.
In questo errare tra Alba, Torino e Genova, il percorso stilistico di Giuseppe Rocca prende una direzione autonoma e per certi aspetti anomala rispetto al repertorio liutario italiano dell’Ottocento: diversamente da altri artefici che nelle diverse regioni continuarono sul segno delle loro tradizioni locali evolvendole senza significativi scarti, Rocca una volta affrancatosi dalla bottega del maestro Pressenda riuscì a portarsi prima di altri con determinazione ed efficacia verso la liuteria classica. Se nel suo primo periodo Rocca seguì con fedeltà e disciplina lo stile del maestro, non appena si fu reso autonomo, diede inizio ad un processo stilistico evolutivo che oggi colpisce per lucida autonomia e determinazione. Fu grazie all’incontro con Luigi Tarisio che il Rocca entrò in contatto con i capolavori cremonesi, e nella moltitudine di violini che il collezionista commerciante maneggiava, due in particolare furono determinanti nel suo percorso liutario, il “Messia” di Antonio Stradivari del 1716 e l’”Alard” di Giuseppe Guarneri “del Gesù” del 1742. Nell’osservare oggi l’attenzione di Rocca ai più minuti dettagli stilistici e costruttivi possiamo certamente immaginare che ne abbia potuto disporre con un certo agio, tanto felice è in entrambi l’esito interpretativo. Da allora, si era circa nel 1843, Giuseppe Rocca si dedicherà esclusivamente a questi due modelli, dei quali fornirà nei periodi successivi interpretazioni che differiscono per ispirazione, materiali, vernici ma che mantengono sempre e comunque un’impronta inconfondibile: dalle versioni più curate e fedeli, ad altre più libere e in qualche modo noncuranti che rispecchiano le difficoltà di una vita tormentata, sempre trapela la capacità di rispettare il modello e lo stile senza mai celare la propria onesta personalità; in questa attitudine a bilanciare rispetto dell’antico e libera interpretazione sta la grandezza, la modernità di Rocca e la sua distanza rispetto ad esempio al gran numero di copie del “Messia” eseguite soprattutto in Francia e alla fortuna che queste ebbero negli ultimi decenni dell’Ottocento, in esemplari riproposti con pari fedeltà e monotonia, con uguale giustezza e banalità.
Giuseppe Rocca con tenacia si propose a diverse esposizioni nazionali ed internazionali, affrontate e risolte con fortune alterne: non sempre le giurie furono indulgenti nei suoi confronti, e per somma ironia il suo lavoro, spesso presentato vicino ai violini delle ditte concorrenti di Mirecourt, veniva talvolta giudicato inferiore poiché i suoi strumenti per “il lavoro alquanto ordinario e la vernice disunita tanto che sembri non sieno per ancho del tutto finiti”. Un’altra giuria invece stigmatizzò che “l’aver messo 14 corde alla sua chitarra è innovazione poco felice”: ancora sul filo dell’ironia, verso la fine dell’Ottocento le chitarre fornite di bassi aggiunti, dette “chitarre arpa” diverranno di gran moda in Italia, nell’Europa Austro-Ungarica e perfino nelle Americhe.
Il periodo genovese di Rocca infine fu in passato ingiustamente definito come inferiore per qualità e ispirazione: in questi strumenti sono spesso evidenti i riflessi delle sue difficoltà personali, dato il legno più economico a volte impiegato quale l’acero americano, il pioppo (a volte persino tarlato), eppure proprio in questi anni Giuseppe riesce ad essere sempre creativo, forse suo malgrado, e senz’altro più imprevedibile; le qualità tonali inoltre sono sempre assai rimarchevoli.
In queste pagine viene proposto uno strumento del 1839, costruito quindi nei primi anni di attività autonoma di Giuseppe Rocca: violino dalle eccellenti condizioni conservative, oggi felicemente accasato in un’importante collezione piemontese, rispetto all’origine ha perso solamente il ponticello e i piroli, fatto questo particolarmente doloroso, poiché accaduto in tempi a noi non lontani.
L’etichetta originale che giace indisturbata all’interno porta le tre iniziali dell’autore che, disposte a triangolo, racchiudono al centro un’arpa: non vi sono altre firme o scritte, il marchio a fuoco con le iniziali del suo nome inscritte in un ovale comparirà poco più tardi e tuttavia, osservando l’interno della cassetta dei piroli, notiamo sotto il capotasto le due lettere ‘GR’ tracciate con pennello e inchiostro nero.
La costruzione interna è curatissima: le controfasce in salice sono ancora appoggiate ai tasselli secondo la tecnica appresa da Pressenda, e furono alleggerite e raccordate al fondo con attenzione quasi maniacale, nessun segno di lavorazione è stato lasciato alla vista. I tasselli, anch’essi in salice, sono piuttosto ampi e rivelatori di una forma interna dagli scassi centrali inclinati; all’esterno le punte delle fasce sono state sapientemente assottigliate e arrotondate e un filetto rifinisce la giunta delle fasce al bottone: suggestivo il capotasto inferiore originale, in ebano incassato nella fascia e il delicato bottone in avorio tornito.
L’esecuzione delle bombature rivela una matura tecnica scultorea e una certa ispirazione classica; piuttosto basse in altezza e prive di un piano sulla sesta longitudinale, scendono con garbo fino a lentamente smagrirsi verso i bordi; bella la finitura a rasiera che ha lasciato marcata e in leggera emergenza la fibra dell’abete della tavola armonica. Il modello delle effe mostra ancora chiaramente l’influenza del maestro Pressenda, seppure l’esecuzione più morbida e sinuosa ne riveli già un certo distacco; i fusti furono tagliati inclinati verso l’interno della tavola con un affilato coltello, mentre una profonda e decisa sguscia sulle palette inferiori lascia in evidenza un delicato bordino sul contorno. Per i filetti Giuseppe Rocca scelse legno di ebano per il ‘nero’ e un acero dalla lunga e scura specchiatura per il ‘bianco’: incassati a giusta profondità rispetto al bordo, furono inseriti nei corpi superiori ed inferiori in pezzi unici senza giunte, particolare costruttivo questo che verrà ripreso in età matura dal figlio Enrico.
La scultura del ricciolo ancora ci mostra il desiderio di autonomia di Rocca nei confronti del suo maestro: l’occhio viene sensibilmente ridotto ed aggraziato da una chiusura piuttosto alta, scolpito con una naturalezza priva di leziosità; la cassetta dei piroli è ampia con pareti verticali tagliate a scalpello e smussi esterni consistenti, il dorso garbatamente sgusciato mostra un leggerissimo segno di tracciatura centrale. La scultura del profilo, elegante e calibrata, venne impreziosita dalla finitura ad inchiostro dello smusso, caratteristica questa sempre presente negli strumenti di Rocca.
Meravigliosa infine la vernice che ancora ricopre interamente lo strumento: fortunatamente sopravvissuta ad interventi di pulitura e polishing, si presenta oggi in tutta la sua freschezza incontaminata, rivelatrice di una pasta spessa e duttile, trasparente eppure così fortemente pigmentata da un rosso bruno a volte cupo, a volte sorprendentemente luminoso; segnata da una fitta craquelure, reca su di sé i segni del tempo che, con lenta gentilezza, ne ha fissato la sua immagine pura.